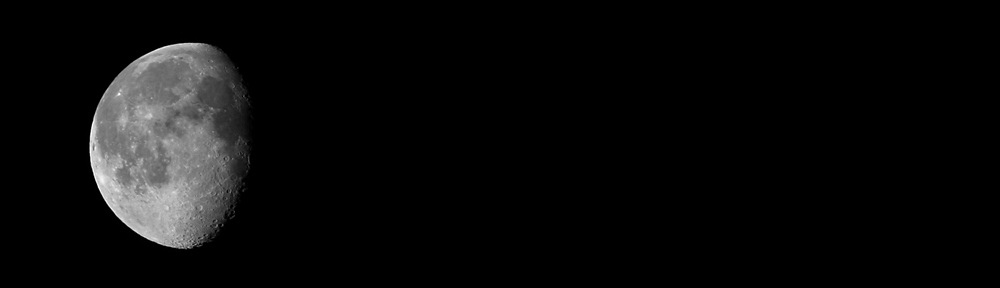Bevo qualcosa per festeggiare il compleanno di un amico.
Passeggio per le vie del centro, cercando di sorridere ai passanti, a chi non cede il passo, a chi pensa che ci sia ancora qualcosa da dire, a qualche interlocutrice occasionale.
L’aria è buona. È una bella serata, nulla da eccepire.
“Auguri, ragazzo!”
“Come, come?”, interviene uno sconosciuto “è il tuo compleanno?”
“Sì, trent’anni!”
“Auguri!!!”
Nessun coro -qualcuno ce ne scampi e liberi- e “buonanotte, ci si vede domani sera, e se ricapiti per il centro si fa un aperitivo prima della cena.”
“Va bene, a domani.”
Torno verso la guinness-mobile, accendo l’ultima sigaretta e resto a rimirare le mura e la bellezza, un po’ soffocata, di questa città (ripenso anche alle parole non gentili spese per il nostro “amato” sindaco, nel frattempo).
Sto per buttare la cicca quando, ad un certo punto, mi sembra di riconoscere un ragazzo.
“Ma sì, cazzo, è Beppe!”.
Muove passi incerti, il ragazzo, perché è visibilmente “fatto”. Anzi, no, “stra-fatto”.
“Beppe! Ma come minchia ti sei ridotto?!”
“Perché, si vede?”
“Nooooooooooooo. Certo che si vede! Dove stai andando?”
“A casa, a piedi, ma fin laggiù io non ci arrivo…”
“Vieni, sali in macchina, rincoglionito!”
“Ma davvero si vede che non mi reggo in piedi?”
“Certo che si vede che non ti reggi in piedi!”
“Oddio, e adesso come faccio a rientrare in casa?”
“Con le chiavi, Beppe.”
“Non ce le ho! Che cosa dico a mia madre?”
Resto in silenzio. Ripenso ai miei diciotto anni. Ripenso alle prime sere alla Public.
Sono certo di non essermi mai ridotto in quello stato. All’epoca no, ne sono sicuro.
“Beppe, non sono tuo padre, ma cazzo! Non puoi ridurti così!”
“Eh, lo so, hai ragione, ma il sabato è così!”
“No, Beppe, è venerdì.”
“Ah, giusto”.
Arrivo sotto casa sua. Aspetto che scenda. Verifico che riesca a mettere insieme i propri passi e dopo riparto.
Riparto, ma penso che, in tutto questo, ci sia qualcosa di profondamente sbagliato.