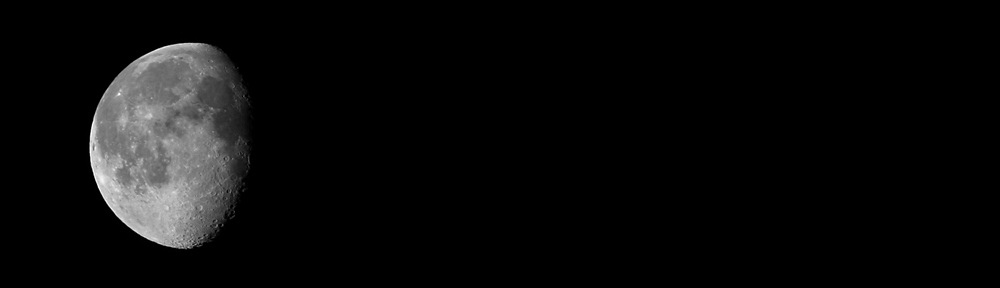Archivi tag: io
5 luglio 2014
Rischiare la vita è una cosa dannatamente poetica, tanto poetica da essere anche un dannato cliché. Pensate ai film, alle opere letterarie e, quindi, ai vostri eroi e antieroi, che rischiano la vita. Pensate bene a quello che riesce a fare l’Autore (se è uno bravo, ovviamente). Siete lì, incollati allo schermo o alla pagina giusta e… il vostro beniamino rischia di lasciarvi, per sempre.
Rischiare la vita, essere sul punto di morire.
No, non c’è poesia. Davanti agli occhi non passa un cazzo di film, ché la vita è già lì, alle tue spalle, che ti sta salutando.
Il 5 di luglio io non ho visto alcun film. Ho visto nero (il proverbiale “nero più nero della pece”), ho sentito, nelle orecchie e sulla pelle, un grande schianto. Nessun fottuto film.
E poi -ah, la poesia- ho riaperto gli occhi e il cielo era sopra di me. Blu.
Voglio credere che il fatto di aver rischiato la pelle sia qualcosa di più che “Nero! Bum! Blu!”, senza, però, dover ricorrere a quelle religiose fantasie che tanto vanno di moda, che tanto fanno pensare e gridare al miracolo.
Dopo quasi quattro mesi sono più o meno a posto, con un osso fuori asse (ah, mia amata clavicola) e altre fratture in fase di guarigione.
Se stai leggendo questo articolo e sei un centauro, fammi un favore: usa sempre il casco, anche per percorrere cento metri. E non fare l’asino, che magari, tra qualche mese, ci si rivede su Via Maggio.
Una dura lotta.
Un giorno, mio padre si avvicinò e, guardandomi molto serenamente, mi disse:
“Figlio mio, smetti di fumare, per favore.”
Lì per lì, rimasi un po’ sorpreso da quel modo così gentile. E, sempre lì per lì, gli risposi:
“Se me lo dici così, quasi quasi, smetto.”
Quel “quasi quasi” mi ha fregato per anni.
Ogni volta che mio padre mi chiedeva perché non smettessi di fumare (tre o quattro volte all’anno, il numero delle mie visite ai miei), io gli rispondevo: “Perché so esattamente quando smetterò di fumare.”
Pensavo a un evento speciale, a qualcosa di veramente e banalmente bello.
Del resto, anche Niccolò cantava: “Non si smette di fumare in un giorno qualunque…”
E così, nella mia testa, cercavo di associare il momento in cui avrei spento l’ultima sigaretta a un istante che non avrei mai potuto scordare.
E invece.
Il giorno è arrivato, senza essere stato annunciato, senza un motivo particolare. Come se, a ben vedere, non possa avere che “giorni qualunque”, nella mia vita.
Oh, sì, così suona un po’ triste tutta la faccenda, ma la cosa importante è che alle 23.49 del 2 aprile 2013, io abbia acceso l’ultima sigaretta. E non quell’ultima sigaretta di cosiniana memoria, ma proprio l’ultima.
Non c’è da essere fieri, né da pensare a chissà quale eroico gesto. E la lotta contro la voglia di accenderne una è davvero dura. Più dura di quanto pensassi.
C’è, tuttavia, un pensiero che mi consola: siccome è tutto inutile, il fatto di voler rendere ancora più inutile quest’ultimo gesto, beh, non mi alletta. Ergo: resisterò e un giorno, in quel giorno speciale, potrò compiere un altro gesto, forse più grandioso e meno egoista.
Quando torni.
C’è sempre la pioggia, quando torni, e le temperature sono poco clementi, come i ricordi.
Ci sono facce e occhi che ti assomigliano; camminano, oppure guidano automobili del futuro, oppure ancora corrono su strade che stanno perdendo pezzi d’asfalto, a causa del tempo.
C’è sempre una domanda, alla quale non so rispondere, quando torni. È l’unica domanda che mi tormenta da mesi, ed è forse l’unica domanda alla quale non saprò mai dare risposta. È una voce lontana a pormela, e ha una cadenza buffa, che assomiglia molto alla tua.
C’è sempre un vento freddo, quando torni, e la sensazione di non riuscire ad arrivare al binario, di non riuscire a vederti salire su quell’ultimo treno: “Grazie di essere venuto al binario, sai?”. Ci sono molti passanti, tratti che non riesco più a separare dai tuoi. E meno male.
C’è sempre un motivo, quando torni. E quel motivo non è una domanda, è una canzone.
Mi sono sempre augurato che una notte, in una notte di malessere, ti potessi svegliare con questa canzone piantata nel cervello, così come successe a me, quella puttana d’una notte.
Ci sono sempre le ultime parole, quando torni. Le parole di una donna di una bellezza disarmante. Tu. Bella e oltremodo affascinante, padrona del mondo e di mille emozioni. E chissà se prima o poi riuscirai a chiedermi se sono vivo, anziché tornare così, assieme alle crepe di ciò che fu.
Ci sono sempre ottimi motivi per sorridere, quando torni. Ma stasera li voglio mettere da parte, e pensare che no, non avrei voluto che finisse. E che finisse così. Ti dedico una lacrima. Solo una.
Nomadiade
Sarà la bellezza a salvarmi, quando non avrò più il soffio vitale, e allora saranno solo le mie ceneri a sussurrare.
O forse, ancor prima, il canto di una delle sirene di Ulisse, poiché in quel momento sarò deriva, e non natante, a trasportare quello che cercano altri migranti, o viandanti occasionali, tra flutti umorali secreti da me.
Sarà la notte a salvarmi, in un più recente contesto urbano, con il suono di note taglienti e canti strozzati, graffianti, per niente melodici.
Sarà la gomma bruciata, tra le curve fatte di sassi e sterri, e qualsiasi altra strada nuova che non conosco.
Sarà, in una dimensione che non conosco, il nuovo soffio vitale a destarmi, e a ricondurmi qui, tra queste pagine, che altro non sono che lacrime e non colore. E ombra.
Nightfall in Middle Earth
Correva l’anno 1998.
“Oh, hai sentito che è uscito il nuovo album dei Blind Guardian?”
“Eh, sì.”
“Ma che cos’è “Mirror Mirror”?!”
“Gran pezzo, già.”
Però, insomma, io ero legato ai nostri cantautori, e quindi preferivo brani meno “power” e meno “speed”.
Sono sempre stato affezionato alle “ballad” (poi la smetto con gli anglicismi, giuro).
E poi, in quel periodo, ero rapito da “Up” dei R.E.M., ma quella è un’altra storia.
Così, di Nightfall, ascoltavo a ripetizione “The minstrel”, un mini-brano, del quale scrissi i versi in ogni dove.
Buonanotte, gente.
So I stand still
In front of the crowd
Excited faces
What will be next?
I still don’t have a clue
Come il vento a novembre
Un giorno passato a pensare all’indelicatezza della sincerità.
Un giorno passato a smaltire una sensazione che non mi appartiene.
Un giorno passato a pensare che non ho più segreti, né limiti, né confini.
Un giorno passato. L’ennesimo. Lontano da chiunque.
Una notizia sul giornale.
C’è meno transito, ultimamente. I lampioni lavorano di meno, come le ombre, i marciapiedi possono tirare un sospiro di sollievo, i comignoli iniziano a sbuffare e anche io, vedendoli, mi metto a sbuffare.
Fumo.
C’è meno fumo, ultimamente. I posaceneri riposano, sognando d’ardere come tizzoni, il terrazzo non mi riconosce più, tutte le luci stanno fuori ad attendere il mio ritorno.
Un treno.
Vorrei salirci adesso, magari contrarre una malattia epidermica (“what don’t kill you make you more strong”), tuffarmi con orecchie e cuore tra le carezze e le rasoiate delle canzoni di quei quattro cavalieri.
Un gentiluomo.
Così il mio pensiero si scusa con le mie orecchie, e consiglia l’ascolto di musica nuova. Qualsiasi cosa. Basta che sia “post”, direbbe un caro amico. Sigur, dico io. Rós, dice l’altro. Leggerezza e delicatezza.
Una gentildonna.
Rivesto l’ambiente di tappeti sonori, di immagini di luoghi freddi e di luci buie, che faticano a star dietro al passo della notte.
Oscurità.
Ci ritorno, dopo aver passato un giorno ad ascoltare musica.
E a tendere a non desiderare più nulla.
(E ad avercela quasi fatta.)
Fisioterapia
Da diversi giorni guardo la mia mano, cerco la testa del quarto metacarpo, la tocco, ci parlo: “Vieni fuori, dai! Non essere timida!”. Macché, niente da fare.
Sono stato un coglione, e questa è la punizione che merito: l’imperfezione.
Oh, no, non che prima fosse perfetta, ma la mia manona era forte e senza paura. Ora lo è un po’ meno ed è gonfia come un panino “cotto e mozzarella”. Un panino senza verve, del tutto insignificante.
Un consiglio: non litigate mai con un muro o con una fisioterapista, a meno che non siano a debita distanza da voi.
Auguri!
Venerdì giovane
Bevo qualcosa per festeggiare il compleanno di un amico.
Passeggio per le vie del centro, cercando di sorridere ai passanti, a chi non cede il passo, a chi pensa che ci sia ancora qualcosa da dire, a qualche interlocutrice occasionale.
L’aria è buona. È una bella serata, nulla da eccepire.
“Auguri, ragazzo!”
“Come, come?”, interviene uno sconosciuto “è il tuo compleanno?”
“Sì, trent’anni!”
“Auguri!!!”
Nessun coro -qualcuno ce ne scampi e liberi- e “buonanotte, ci si vede domani sera, e se ricapiti per il centro si fa un aperitivo prima della cena.”
“Va bene, a domani.”
Torno verso la guinness-mobile, accendo l’ultima sigaretta e resto a rimirare le mura e la bellezza, un po’ soffocata, di questa città (ripenso anche alle parole non gentili spese per il nostro “amato” sindaco, nel frattempo).
Sto per buttare la cicca quando, ad un certo punto, mi sembra di riconoscere un ragazzo.
“Ma sì, cazzo, è Beppe!”.
Muove passi incerti, il ragazzo, perché è visibilmente “fatto”. Anzi, no, “stra-fatto”.
“Beppe! Ma come minchia ti sei ridotto?!”
“Perché, si vede?”
“Nooooooooooooo. Certo che si vede! Dove stai andando?”
“A casa, a piedi, ma fin laggiù io non ci arrivo…”
“Vieni, sali in macchina, rincoglionito!”
“Ma davvero si vede che non mi reggo in piedi?”
“Certo che si vede che non ti reggi in piedi!”
“Oddio, e adesso come faccio a rientrare in casa?”
“Con le chiavi, Beppe.”
“Non ce le ho! Che cosa dico a mia madre?”
Resto in silenzio. Ripenso ai miei diciotto anni. Ripenso alle prime sere alla Public.
Sono certo di non essermi mai ridotto in quello stato. All’epoca no, ne sono sicuro.
“Beppe, non sono tuo padre, ma cazzo! Non puoi ridurti così!”
“Eh, lo so, hai ragione, ma il sabato è così!”
“No, Beppe, è venerdì.”
“Ah, giusto”.
Arrivo sotto casa sua. Aspetto che scenda. Verifico che riesca a mettere insieme i propri passi e dopo riparto.
Riparto, ma penso che, in tutto questo, ci sia qualcosa di profondamente sbagliato.