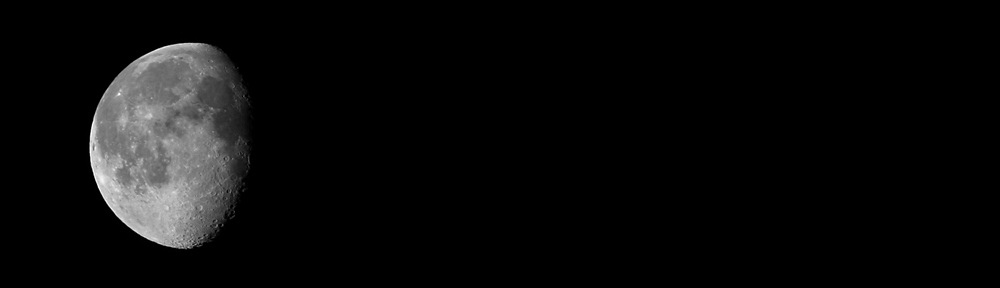Capita anche a me di avere ricordi vaghi, confusi.
Mi succede quando inizio a superare ciò ch’è legato a quegli stessi ricordi; quando vedo da lontano qualcosa che prima si muoveva e ora è inerme; una cosa che si allontana, come se la stessi guardando da uno specchietto retrovisore.
Sono in automobile, aspetto che mia sorella compri le ultime cose.
È quasi Natale e c’è sempre quell’atmosfera strana, quando è quasi Natale.
So che tra poco sarò a casa con i miei, che non litigherò, so anche che, tra qualche ora, mi metterò in viaggio per venire a regalarti un sorriso e una giornata serena, senza litigi. Con tutti gli “speriamo” del caso, senz’altro.
Sono in automobile, consapevole del fatto che tutto, ormai, stia andando a rotoli, trascinato com’è, da mesi, da un’insofferenza atomica.
È tutto così lontano da quel primo bacio, dalle fughe, da quegli incontri in clandestinità. Non c’è il freddo di Bologna, non ci sono i colori di Venezia, né il fascino del lungarno pisano.
Però è quasi Natale, dai.
Dai, che magari ci facciamo un bel regalo e cessiamo queste stupide ostilità.
Scarto un cd. L’ho trovato a poco, originale, e quindi ho deciso di acquistarlo. “Il ballo di S. Vito”.
Quante volte avrò ascoltato quell’album? Centinaia, eppure, rimettendolo su, mi faccio colpire da una traccia.
Prendo il telefono.
“Mon amour, stavo riascoltando “Le case”. Trovo che sia straziante. Trovo che c’entri troppo con questi giorni. E niente, così, volevo dirtelo. Ma tu aspettami, ché tra un paio di giorni arrivo.
Ma tu te la ricordi, “Le case”?”
“Sì, Rug, me la ricordo. Ma non ascoltare cose tristi.”
I ricordi sono vaghi.
Sono contento di ascoltare cose tristi. Perché sono triste.
La musica, anche questa volta, non mi tradisce.
gesti alzati in fretta nel mattino
calda assenza a fianco al comodino
treni, stazioni, biglietti
sepolti nei letti…
È quasi Natale.
Dai, che magari non andrà così.
E invece.